Settembre 2016
Chi sono i CLOWN?
Alla ricerca di un'identità tra sogno e stereotipo
Ester Procopio
Il clown Grock. L’espressione riunisce il clown-bambino e l’uomo adulto: è buffa, ma anche malinconica. Aiutata dalla ricca biblioteca messa insieme in anni di brillante carriera da mio padre, attore comico o – come meglio ama definirsi – clown, vorrei dare una risposta a questa domanda… o più d’una, se una non bastasse. La prima consapevolezza che mi balza alla mente è: i clown non sono più, o non sono soltanto, gli uomini truccati e travestiti del circo, caricature buffe, ingabbiate in un costume storicamente codificato e socialmente accettato che li rende riconoscibili, perciò anche poco eversivi. Così come, con l’avvento della “commedia di carattere” di Molière e Goldoni, la figura del buffone era trasmigrata dalla commedia dell’arte [1] all’arena del circo, evolvendosi da maschera in clown e qui trovando terreno fertile per far crescere la propria arte, allo stesso modo, con l’avvento della banalizzazione e mercificazione del clown, reso caricatura di se stesso fino al punto (sigh!) di diventare la mascotte di una catena di fast-food, ecco il clown migrare ancora e cercare altrove, persino oltre il circo, un palcoscenico in cui svilupparsi. Già una prima “migrazione” era avvenuta col cinema: basti pensare ai celeberrimi clown cinematografici Buster Keaton, Charlie Chaplin o Stanlio e Ollio. Purtroppo, a mio avviso, il cinema ha teso isolare “ai piani alti” questi fortunati esperimenti di commistione di arte circense e filmica: già le pellicole di un Jacques Tatì (Mon oncle, Monsieur Hulot, Playtime), ad esempio, paiono create per un pubblico di specialisti. Nelle commedie ridicole e prevedibili che spesso fan tanto incasso al botteghino poco, pochissimo si salva dell’originale comicità clownesca. “Quo vado?” quale debito assolve nei confronti di “Tempi moderni”? Dunque chi sono i clown e dove si trovano? La domanda è martellante e fa irretire chi si accorga che la maggior parte della gente risponderebbe: alle feste di compleanno! Negli angoli dell’ipermercato a distribuire palloncini ai bambini! Oppure ancora, sentirsi rispondere che i clown sono “quelli con il trucco pesante, le scarpe giganti e la parrucca arancione” e che “fanno paura” (s’è persino creata una categoria di fobia apposita dei clown, la coulrofobia). Ma questi non sono i clown, sono lo stereotipo, la parodia orrenda dei clown, non a caso così efficacemente sfruttata da Stephen King nel best-seller “It”. Un clown che si truccasse così pesantemente da far paura sarebbe la negazione stessa del proprio nome: non è sufficiente, o meglio, non è necessario travestirsi o truccarsi per essere un clown, perché la sua essenza, il suo compito è proporre un’evasione, fare una caricatura dell’uomo o – per usare le parole di Fellini – il clown «è uno specchio in cui l’uomo si rivede in grottesca, buffonesca, deforme immagine. È proprio l’ombra.» (F. Fellini, Un viaggio nell’ombra, p. 36 in “I clown”). E quanto più l’uomo tende a negare, a nascondere o ingabbiare questo lato di sé, tanto più il clown sarà lì a ricordarglielo, a decostruire l’altare eretto, a mettere in evidenza l’istintualità repressa, a fungere da molla di un riso liberatorio e incensurato. I mezzi attraverso cui ottenere questo scopo si sono raffinati nel tempo, dando forma a un vero e proprio mestiere con le sue regole e la sua scuola, ma nulla vieta che essi possano mutare, così come mutano i tempi e i problemi dell’uomo. Dirò di più: nel momento in cui il clown cessa di evolversi al passo coi tempi – non sacrificando quindi tradizioni e clichés – e si stabilizza in modo permanente in una determinata forma (ad esempio l’uomo con le scarpe giganti e il naso rosso), allora la sua efficacia sociale diminuisce a tal punto da determinarne il declino; finisce per perdere lo scopo della sua esistenza. Il clown non può scomparire, ma necessariamente deve evolversi, spostarsi in un altro luogo in cui possa essere accolto senza censure e sperimentare un contatto diretto con l’uomo, se necessario per sopravvivere. È all’uomo che il clown deve guardare, mai a se stesso. Dove siano o dove saranno i clown non è facile dirlo, ma sono certa che essi si trovino meno di quanto si pensi nei circhi e ancora meno in animatori truccati per feste di compleanno. Una società che tende a dire “il clown è per bambini” poco ha capito del clown. Il clown è il bambino, non è per il bambino: lui è per l’uomo. Ricordavo molto bene di una cassetta (all’epoca non esistevano i dvd) del clown Grock, che mio padre mi faceva vedere da piccola e che adoravo (credo si tratti del secondo film di Grock, “Grock presenta Grock”, del 1931; ho visto che esistono degli spezzoni su youtube, non in italiano [2]: l’ho rivista per scrivere questo articolo e devo dire che, a distanza di quindici anni, l’ho goduta anche di più e mi ha fatta ridere, d’un riso spontaneo e sincero. Grock – che sapeva suonare moltissimi strumenti, fare acrobazie ed era poliglotta – ha riconquistato il mio cuore con la sua spontaneità bambina… una spontaneità di cui abbiamo nostalgia da che abbiamo lasciato l’infanzia alle spalle e che il clown sa tenere viva, e farci rivivere. Ma, forse, per riviverla basterebbe cercare il clown che abbiamo dentro.
___________________________
[1] Modalità di fare teatro diffusa nel‘600 che si basava sull’improvvisazione (quindi sull’assenza di un testo scritto da recitare) e sull’utilizzo delle maschere (si definiscono proprio nell’ambito della commedia dell’arte maschere quali Arlecchino, Pantalone, etc). La commedia dell’arte viene utilizzata e “nobilitata” da Goldoni nel secolo successivo ma proprio allora cessa di esistere, perdendo il suo carattere di performance improvvisata.
[2] Per chi volesse vederselo, il link: https://www.youtube.com/watch?v=iZfKMcRwKMc
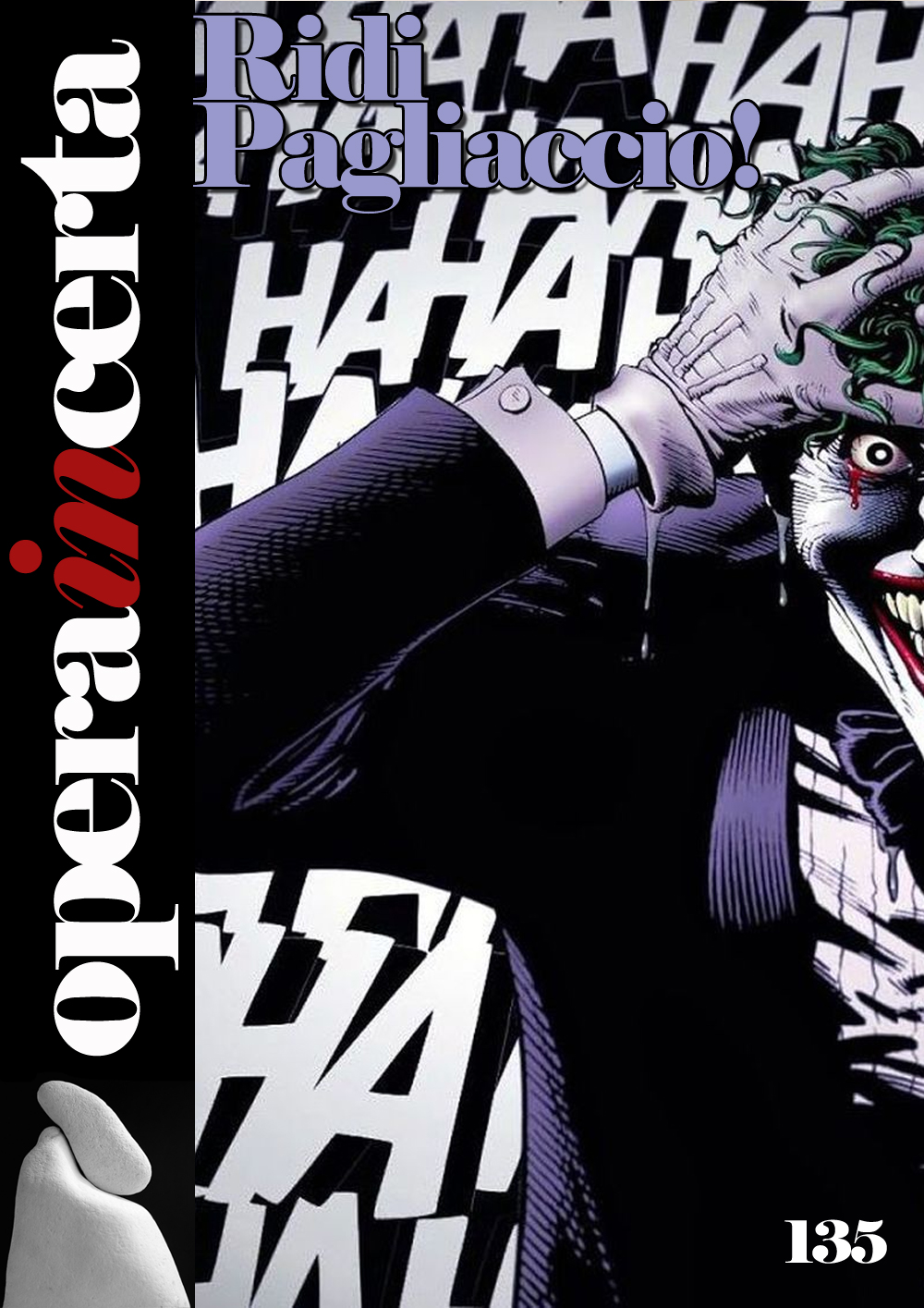
© 2023 Operaincerta. Design by W3Layouts
