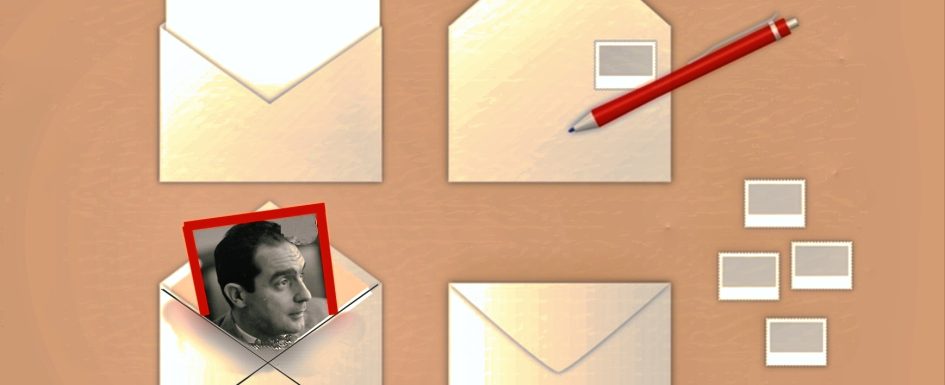
Quando nei giorni tra il 29 aprile e il 3 maggio 1963, invitato al Premio Internazionale degli Editori a Corfù, pronunciò il suo intervento a sostegno della candidatura de La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, Italo Calvino (1923-1985) aveva pubblicato nel marzo dello stesso anno La giornata di uno scrutatore (1963) e possiamo immaginare che quella verità proclamata circa il ruolo della letteratura e di chi scrive appartenesse anche a lui, e alla genesi del suo racconto.
«La realtà del mondo si presenta ai nostri occhi multipla, spinosa, a strati fittamente sovrapposti. Come un carciofo» – aveva spiegato – «Ciò che conta per noi nell’opera letteraria è la possibilità di continuare a sfogliarla come un carciofo infinito, scoprendo dimensioni di lettura sempre nuove.» La metafora dell’ortaggio sulla tavola si era rivelata congeniale così come per Pablo Neruda, che nelle Odi elementari (1954) del carciofo aveva cantato in versi la militanza al mercato, in attesa dell’acquirente che ne avrebbe vissuto l’esperienza del gusto, partecipando al lettore l’emozione per il manifestarsi della vita, quando «squama per squama spogliamo la delizia e/ mangiamo la pacifica pasta/ del suo cuore verde».
Per ammissione dello stesso Calvino, La giornata di uno scrutatore era innanzitutto un «racconto»: così ne parlava nelle lettere agli scrittori e ai critici, ringraziando per le recensioni o soffermandosi sulle ulteriori riflessioni innescate dal confronto e dalla lettura. «Ho letto il tuo racconto, e mi pare bellissima cosa. Piuttosto sciocco, invece, mi pare quel che qualcuno ne ha scritto» – lo rassicurava Leonardo Sciascia, il 23 marzo 1963, alludendo alla furbizia d’autore ingiustamente attribuita dalla recensione di Oreste del Buono – «Ma sto facendo anch’io esperienza della impreparazione dei critici: evidentissima appena si accostano a un racconto ‘storico’ (com’è in effetti anche il tuo).» E ancora Sciascia sarebbe stato «contento, fraternamente contento» (20 maggio 1963), nel congratularsi per l’assegnazione del Premio letterario Veillon al racconto.
In febbraio, Calvino aveva condiviso la propria concitazione a Lanfranco Caretti, per giustificarsi del ritardo nel partecipare ai preparativi per la conversazione con i suoi studenti all’Università di Pavia, perché «tutto impegnato a finire un racconto, che mi costava molta concentrazione e sforzo, e non volevo distrarmi, né prendere impegni. Ora il racconto è finito; non so ancora se ne sono contento o no; ma qui lo vogliono pubblicare subito in volume, (…) tanto che uscirebbe al principio di marzo. …definirebbe la mia via ormai come quella della riflessione morale sulle esperienze della nostra epoca, escludendo la direzione «favolistica» e ogni tentazione «sperimentale»; e comunque quanto di più lontano dal clima di facilità e piacevolezza che imperversa ora in Italia» (8 febbraio 1963).
Reportage, pamphlet, meditazione filosofica, il «racconto pensoso» – per definizione dello stesso autore – ha una genesi articolata e una gestazione di ben dieci anni. «Il protagonista è un pignolo e un noioso e terribilmente ideologico» – così nella lettera del 21 maggio 1963 ad Aldo Camerino – «ma gli ex-giovani della mia leva e ancor più molti dei giovani che vengon su adesso, sono così, ossia molto peggio (perchè sicuri di tutto e senza sfumature). E io volevo fare il racconto d’uno di loro (che fosse nello stesso tempo anche me, perché i personaggi riescono solo se sono, in qualche misura, anche autoritratti)» (21 maggio 1963).
«Autoritratti» prelude all’ autobiografia, una scelta che sottende alle intenzioni dell’autore e alle due opposte vocazioni della letteratura, indagate nelle Lezioni Americane (1988), nelle pagine sulla Leggerezza: « …l’una tende a fare del linguaggio un elemento senza peso, che aleggia sopra le cose come una nube, o meglio un pulviscolo sottile, o meglio ancora come un campo d’impulsi magnetici; l’altra tende a comunicare al linguaggio il peso, lo spessore, la concretezza delle cose, dei corpi, delle sensazioni».
Se la produzione fantastica aveva espresso la prima, adesso La giornata di uno scrutatore dava spazio alla seconda, assumendo nella concretezza delle “cose” la presentazione del Cottolengo o Piccola casa della Divina Provvidenza, l’istituto di carità di Torino così soprannominato dal nome del fondatore, del suo ambiente e dei preparativi per lo svolgimento delle elezioni; in quella dei “corpi” la malattia dei degenti, quale premessa e contestuale limite all’esercizio del voto; e infine nelle “sensazioni” la riflessione dura, logica e commossa dell’autore e dello scrutatore Amerigo Ormea, suo alter ego.
È lo stesso Calvino a riconoscere nel protagonista tracce della propria identità. «Mi interessa l’analisi sulla maturità, cioè questa biografia di Amerigo Ormea che tu sviluppi da quel che sai di me … che vale per me soprattutto per quello che dovrei essere» – scriveva il 30 marzo 1963 ad Augusto Monti, che ne aveva pubblicato una recensione. E l’incidenza di memoria e autobiografia è ancora più evidente nel ripercorrere la gestazione dell’opera.
Nelle prime intenzioni di Calvino, insieme a La speculazione edilizia (1957) e La nuvola di smog (1958), doveva costituire la serie dei tre racconti ambientati negli anni Cinquanta, a descrivere il trapasso in una nuova epoca, ispirato al «groppo lirico-morale, …che decide nel mare delle cose che si possono scrivere quelle che è impossibile non scrivere».
La scrittura attingeva alla vita e all’esperienza: il 7 giugno 1953, Calvino si era recato al Cottolengo da candidato per il Partito Comunista e la vista dei ricoverati, straziati nel corpo e nella mente, lo aveva turbato, forse ancora più dell’ipotesi che il loro voto potesse essere estorto dall’assistenza per mano dei religiosi, in favore della Democrazia Cristiana. Già allora avrebbe voluto scriverne, tuttavia era necessario che le immagini forti di dolore sbiadissero per lasciare spazio alla riflessione. Per questo, Calvino torna al Cottolengo nel 1961 come scrutatore e qui assiste agli episodi che ispirano il racconto di una giornata, alla fine della quale il protagonista Amerigo Ormea si ritroverà cambiato e con lui anche l’autore.
Come Calvino, Amerigo è infatti un uomo laico, anticlericale, razionalista e scettico verso quanto sfugge alla logica materialista. È soprattutto un intellettuale, colui che accetta di «mescolarsi attivamente alla vita pratica, come costruttore, organizzatore, persuasore permanente» (Antonio Gramsci), possiede istinto esplorativo, sa trarre dal passato la lezione per il presente, esercita una funzione cosmopolita ed è dedito al proprio compito. La sua mancata partecipazione alla vita civile priverebbe la società «di un lievito essenziale, quello dell’opera intellettuale, che promuove il mercato delle idee, coltiva la consapevolezza sociale della propria storia, rende meno asfittiche le proposte della politica» (Sabino Cassese). E infatti, se il suffragio universale ha superato quello ristretto, censitario e capacitario, riservato ai possidenti poi agli alfabetizzati, e i cittadini possono partecipare ora alla vita dello Stato, liberi e uguali in ragione dell’art. 3 della Costituzione, da parte sua l’intellettuale può promuovere la formazione dell’opinione pubblica, la rimozione degli ostacoli alla parità di condizioni, l’affermazione della democrazia rappresentativa, sul modello ateniese di kratos (forza), aretè (virtù) ed episteme (competenza); e una nuova cultura, che proponga il rifiuto dell’autoritarismo, l’interesse per le classi popolari, il rinnovamento dell’istruzione, la rivendicazione dei diritti, l’attenzione alla questione meridionale, la gestione del boom economico, il cambiamento politico e sociale. La maggior parte degli intellettuali di quella stagione aderirono alle ideologie di sinistra e così lo stesso Calvino, che lascerà il Partito Comunista nel 1956, a seguito dell’invasione sovietica dell’Ungheria, pur mantenendosi aperto al dialogo.
L’ingresso al Cottolengo pone però Calvino/Amerigo davanti alla sofferenza umana, innescando un cambiamento, e la realtà si rivelerà labirintica, articolata, sfuggente a un’unica verità pragmatica e consolidata. Il dramma umano dei malati, il privilegio ostentato dall’onorevole in visita, il sospetto che i religiosi possano manipolare il voto dei ricoverati fanno scattare la reazione del protagonista, il suo intervento plateale per impedire a una suora di esprimere la preferenza elettorale per conto di un disabile mentale. Subito dopo, però, è investito dal dubbio sulle aporie intrinseche alla democrazia, dal maggiore pericolo tra estorcere un voto, consentendo comunque a un cittadino di esercitare il proprio diritto, o impedirne la partecipazione alle elezioni, negandogli quello stesso diritto.
A spiegare questa contraddizione è la recensione all’opera di Guido Piovene, di cui Calvino nella lettera del 24 maggio 1963 conferma l’interpretazione. La scelta della rappresentazione realistica, in luogo di quella favolistica, per Piovene implica «una sorta di amletismo dell’intellettuale nella civiltà industriale; è ingarbugliato, ondeggiante, con l’intelligenza tesa; vuole esservi dentro e cercare nel tempo stesso la via d’uscita». E ancora: «Si potrebbe partire dalla domanda: si ha diritto di usare come uno strumento passivo, a scopo elettorale, esseri non pensanti? La prima risposta, immediata e politica, è: no. Sotto la risposta politica, si aprono però subito quei risucchi … A che punto si è uomini, a che punto si cessa di esserlo? (…) Quando si può dire questa miseria non ha il diritto di contribuire a decidere? Oppure l’uomo è fatto dalla ricchezza di tutto ciò che esiste, e l’umano ha i confini che gli diamo, di volta in volta, con l’amore?». I quesiti attribuiti al protagonista sono lucidi, netti, taglienti, ma senza risposta, perché lo stesso Calvino è «lo scrittore dell’oggettività di quell’incertezza, in una realtà nella quale stenta non solo a trovare, ma a cercare le essenze».
Se da un lato la ragione induce Amerigo a difendere la democrazia, a impedire che le elezioni assicurino il mantenimento stabile dei potenti, anche attraverso la scelta di votanti che non otterranno alcun guadagno dalla loro azione, dall’altro il suo illuminismo vacilla alla vista del dolore in natura, in un distillato di riflessioni non estranee al giardino di piante, erbe e fiori, «in stato di souffrance, qual individuo più, qual meno», citato nello Zibaldone (1826), né alla meditazione filosofica sulla vita umana delle Operette morali (1824-1832) di Giacomo Leopardi. Nello scontro con la realtà, non vi è soluzione percorribile, sebbene l’amore apra la via della speranza: da un lato, quello per la fidanzata Lia con la notizia della gravidanza e le esitazioni per una nuova vita, dall’altro quello del padre contadino in visita al figlio malato, necessari l’uno all’altro, anche solo nella reciprocità dello sguardo.
Più lo scrutatore Amerigo si addentra nel groviglio tra umanità e democrazia, più la sua esplorazione incontra altre vie, labirintiche e opache. Ogni certezza sembra tramontata, e la vista delle malate nel finale restituisce al protagonista l’affresco spazio-temporale più plausibile nel riconoscimento di un luogo dentro un altro: del Cottolengo dentro Torino, dell’imperfezione dentro l’amore.
Petula Brafa
Riferimenti bibliografici
•Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore, Oscar Mondadori 2014
•Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori 2003
•Italo Calvino, Lettere 1940-1985, a cura di Luca Baranelli, Mondadori 2023
•Italo Calvino, Leonardo Sciascia, L’illuminismo mio e tuo. Carteggio 1953-1985, Oscar Mondadori 2023
•Italo Calvino, Lezioni americane, Mondadori 2003
•Laura Di Nicola, Un’idea di Calvino. Letture critiche e ricerche sul campo, Carocci editore 2024
•AAVV, La città dell’imperfezione. La giornata di uno scrutatore tra tradizione illuministica e complessità dell’umano, a cura di Raffaele Caterina, Rubbettino 2019
•Sabino Cassese, Intellettuali, Il Mulino 2021
•Carlo M.Cipolla, Allegro ma non troppo, Il Mulino 2005
•Nadia Urbinati, Ai confini della democrazia. Opportunità e rischi dell’universalismo democratico, Donzelli Editore 2007
•Pablo Neruda, Ode al vino e altre odi elementari, Passigli Poesia 2015